
Quando l’inquietudine diventa virale
So già che me ne pentirò. Lo dico ogni volta e, ogni volta, ci ricasco.
Già il titolo, The Serbian Dancing Lady, dovrebbe farti capire che è meglio tirare dritto e lasciare perdere. Con tutto quello che c’è da guardare su YouTube, perché dovrei fermarmi davanti a una donna che balla in modo inquietante in una strada deserta illuminata da un lampione. Già, perché?
Perché la curiosità è una brutta bestia, prima di tutto. Ma è davvero tutto qui?
No, infatti non mi limito a guardare. Sebbene sappia benissimo che probabilmente è tutta una messinscena, non riesco a togliermi quell’immagine dalla mente. E così, come milioni di altri utenti prima di me, cedo all’impulso di scorrere i commenti, di cercare altre versioni, altre prove, altre storie simili.
È in quel momento che capisco di essere entrato, senza accorgermene, nel territorio dei creepypasta. Una zona liminale dove la paura non si limita più a essere raccontata, ma diventa partecipazione, rito collettivo digitale.
Ma cos’è, esattamente, un creepypasta?
Il termine nasce dall’unione di creepy “inquietante” e copypasta, cioè il testo copiato e incollato che circola nei forum e nelle chat. Le prime forme embrionali risalgono agli anni ’90, quando si diffondevano tramite e-mail catene di racconti, leggende urbane digitali e storie che minacciavano sventure a chi non le inoltrava. In qualche modo, erano già una prefigurazione, una protocultura digitale dell’orrore. Dalla seconda metà degli anni Duemila il fenomeno si consolida nelle community di 4chan, la piattaforma online anonima fondata nel 2003 da Christopher Poole. Brevi racconti scritti in prima persona, accompagnati da immagini inquietanti o presunte prove fotografiche, cominciano a circolare e diventano virali.
Si trattava di storie verosimili, spesso anonime e difficili da attribuire. Anil Balan ha scritto su Ghost Cities che nonostante queste tracce, le origini esatte dei creepypasta restano sconosciute. Di certo è che in quegli anni di sperimentazione, la rete diventa il nuovo fuoco attorno a cui raccontare la paura, un falò digitale dove l’orrore diventa oggetto di condivisione.
TORINO DEMONIACA
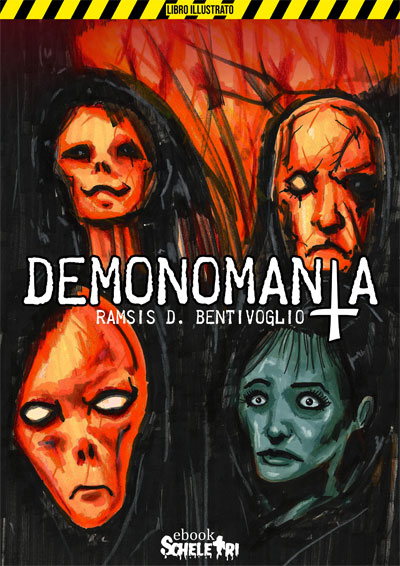 Torino galleggia sulle acque nere della superstizione e della magia. Sulle rive del Po sono adagiati cadaveri di frati impenitenti, satanisti sacrileghi e profeti di sventure. Elsa e Damiano, i giornalisti coinvolti nel delirio collettivo, si trovano a dover combattere contro le legioni di Satana. La città è dilaniata dalla follia primigenia scatenata dagli angeli decaduti. All'Inferno solo il Diavolo potrà salvarti. Disponibile in ebook e cartaceo entrambi illustrati.
Torino galleggia sulle acque nere della superstizione e della magia. Sulle rive del Po sono adagiati cadaveri di frati impenitenti, satanisti sacrileghi e profeti di sventure. Elsa e Damiano, i giornalisti coinvolti nel delirio collettivo, si trovano a dover combattere contro le legioni di Satana. La città è dilaniata dalla follia primigenia scatenata dagli angeli decaduti. All'Inferno solo il Diavolo potrà salvarti. Disponibile in ebook e cartaceo entrambi illustrati.
HORROR PORNO ILLUSTRATO
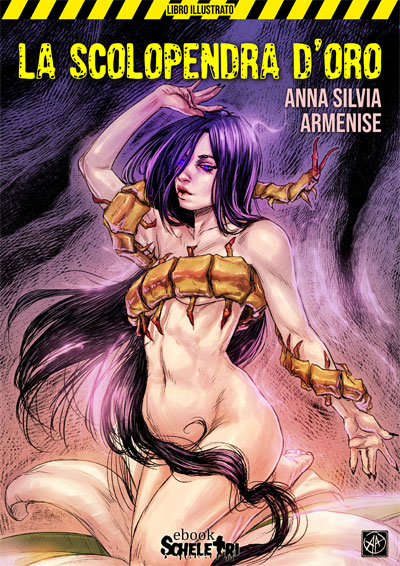 Anni ’70. Tra le strade di una torrida New Orleans, dove il jazz si mescola all’aroma di spezie e ai corpi in vendita, prende vita “La scolopendra d’oro”, novella horror erotica intrisa di sensualità e mistero. Il libro è arricchito con numerose illustrazioni esplicite senza censura realizzate dall'artista Alessandro Amoruso. Disponibile in ebook e cartaceo entrambi illustrati.
Anni ’70. Tra le strade di una torrida New Orleans, dove il jazz si mescola all’aroma di spezie e ai corpi in vendita, prende vita “La scolopendra d’oro”, novella horror erotica intrisa di sensualità e mistero. Il libro è arricchito con numerose illustrazioni esplicite senza censura realizzate dall'artista Alessandro Amoruso. Disponibile in ebook e cartaceo entrambi illustrati.
MANUALE PER SOPRAVVIVERE ALLE STREGHE
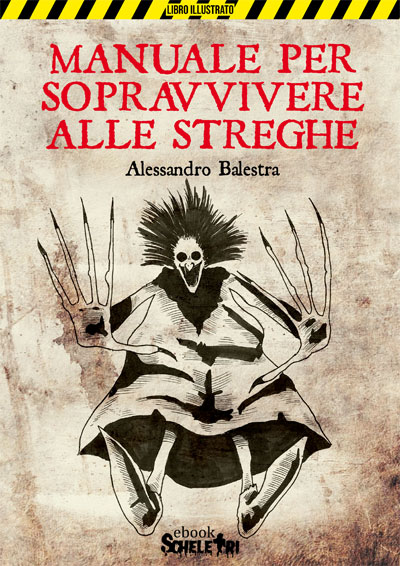 Questo è un testo rivoluzionario che spiega come riconoscere le vere Streghe e affrontarle. Le Streghe sono entità malvagie con un unico obiettivo: seminare caos e distruzione. Lo dimostrano i numerosi casi documentati nel Manuale, tra cui la strage del passo Djatlov, i fatti di Burkittsville, l’incidente alla Darrow Chemical Company e catastrofi di portata mondiale come Chernobyl o l'avvento di Hitler.
Il Manuale è inoltre arricchito da numerose illustrazioni e fotografie inedite e top secret. Disponibile in ebook e cartaceo.
Questo è un testo rivoluzionario che spiega come riconoscere le vere Streghe e affrontarle. Le Streghe sono entità malvagie con un unico obiettivo: seminare caos e distruzione. Lo dimostrano i numerosi casi documentati nel Manuale, tra cui la strage del passo Djatlov, i fatti di Burkittsville, l’incidente alla Darrow Chemical Company e catastrofi di portata mondiale come Chernobyl o l'avvento di Hitler.
Il Manuale è inoltre arricchito da numerose illustrazioni e fotografie inedite e top secret. Disponibile in ebook e cartaceo.
EROS E ORRORE
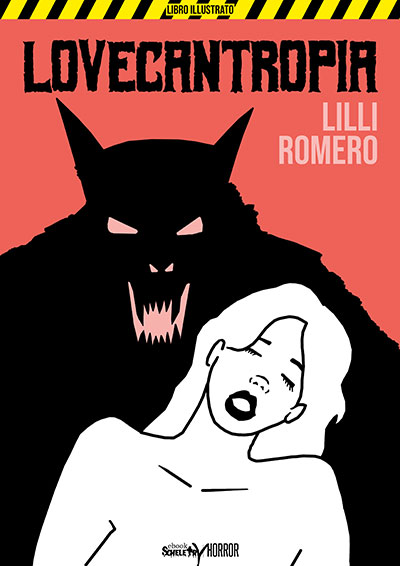 Questo non è un racconto. È una possessione. Una lunga, dolorosa, eccitante possessione. Un ragazzo come tanti ma con un terribile segreto di famiglia, un amore troppo grande per poter restare umano. Lei non è solo una ragazza: è una Dea tatuata, un'ossessione che divora e trasforma. Tra desiderio e dannazione, "Lovecantropia" esplora i confini sottili tra amore e dipendenza, eros e orrore, passione e follia. Disponibile in ebook e cartaceo entrambi con illustrazioni senza censura.
Questo non è un racconto. È una possessione. Una lunga, dolorosa, eccitante possessione. Un ragazzo come tanti ma con un terribile segreto di famiglia, un amore troppo grande per poter restare umano. Lei non è solo una ragazza: è una Dea tatuata, un'ossessione che divora e trasforma. Tra desiderio e dannazione, "Lovecantropia" esplora i confini sottili tra amore e dipendenza, eros e orrore, passione e follia. Disponibile in ebook e cartaceo entrambi con illustrazioni senza censura.
Rimane da chiedersi perché questi frammenti inquietanti ci affascinano tanto.
In primis per la loro capacità di evocare una delle emozioni più potenti e primordiali: la paura. Un’emozione che ci paralizza e, insieme, ci seduce. Leggere o condividere un creepypasta è un modo per avvicinarsi al confine dell’oscuro e al tempo stesso contenerlo entro il perimetro rassicurante della messinscena. La finzione permette di sperimentare il brivido in uno spazio sicuro e la condivisione lo trasforma in un gesto quasi liberatorio. L’uso della prima persona, frequente in questi racconti, crea immedesimazione e coinvolgimento emotivo, dissolvendo la distanza tra narratore e lettore. L’orrore non arriva più dall’esterno, ma dall’interno della stessa comunità di utenti che lo produce e lo condivide. La verosimiglianza e la dimensione partecipativa sono elementi chiave in un racconto che non vive solo nel suo testo, ma nella sua circolazione, nei commenti, nelle varianti, nei riferimenti incrociati. È un racconto collettivo, un folklore digitale in continua trasformazione grazie al contributo e alla partecipazione degli utenti e che proprio per questo non smette mai di sedurre.
I creepypasta funzionano come i meme, sono unità culturali replicabili che si diffondono per imitazione, suscitando emozione, curiosità o spavento. In una cultura che vive di immagini e di velocità, anche la paura deve essere istantanea, comunicabile in pochi secondi, sintetizzata in un volto deformato, in un suono distorto, in un testo che promette un evento inquietante se non lo condividi entro mezzanotte. Studi sulla psicologia dei meme mostrano che la condivisione di contenuti emotivi serve a creare senso di appartenenza e validazione reciproca [Lynn Zubernis - How Memes Help Us Cope. Psychology Today, 03/2024]. Se questo vale per la tristezza o l’ansia, vale a maggior ragione per la paura. Condividere il brivido significa alleggerirlo, trasformarlo in esperienza comune. L’angoscia individuale si scioglie nel sarcasmo dello scettico, nel commento ironico, nella battuta che stempera l’inquietudine.
D’altro canto, recenti studi sui meme digitali hanno mostrato come la circolazione di immagini e testi brevi agisca da veicolo di significati culturali, ma anche di comportamenti e emozioni collettive. Andrei Iulian Stan e Octav Candel hanno dimostrato che condividere meme tristi aumenta i livelli di negatività in un gruppo sociale [The effect of viewing Internet memes on psychology students subjective well-being, 09/2024]. Il progetto MOMENTA, sviluppato nel 2021 tra l’Indian Institute of Technology di Kharagpur e il Qatar Computing Research Institute, è un esperimento d’intelligenza artificiale pensato per riconoscere i meme tossici, quelli che nascondono odio o discriminazione dietro un messaggio apparentemente ironico. Il modello analizza insieme parole e immagini, come se cercasse di leggerne il sottotesto. È la prova che la memetica digitale non è più solo gioco, ma linguaggio, un codice che può divertire o ferire a seconda di chi lo maneggia.
Ci sono diversi studi che mostrano come l’immersione narrativa e la fruizione digitale possano indebolire nei più giovani la distinzione tra realtà e finzione. Una ricerca del Journal of Media Literacy Education del 2017 parla di linea sfocata tra reale e immaginato negli spazi online, mentre altri studi evidenziano come il coinvolgimento emotivo nelle narrazioni visive possa rendere più permeabile il confine tra ciò che è vissuto e ciò che è rappresentato. In questo contesto, l’orrore digitale non è più solo un gioco percettivo, ma un’esperienza che può confondere i piani stessi della percezione.
C’è, nondimeno, qualcosa di antico in tutto questo.
L’umanità ha sempre avuto bisogno di raccontare storie che facessero paura, di esorcizzare l’ignoto attraverso la narrazione. La differenza è che oggi il racconto non si trasmette più oralmente attorno a un fuoco, ma attraverso algoritmi e notifiche, con tutto ciò che ne consegue, rischi compresi. Un creepypasta è, in essenza, una leggenda urbana di Internet e come ogni leggenda urbana riflette le paure di chi la racconta. Ma a differenza delle vecchie storie tramandate attorno al fuoco, la cui funzione era prevalentemente pedagogica e sociale, qui il racconto nasce ovunque e da nessuno, circola, si trasforma, si ripete senza altra funzione che quella di spaventare.
In definitiva, i creepypasta e i meme horror non sono soltanto curiosità morbose della Rete, ma specchi di una cultura che si nutre di emozioni sintetiche e di condivisione compulsiva, senza interrogarsi sui rischi che genera. In un tempo in cui l’attenzione è valuta corrente, non solo online, ricordare che la paura può essere non un ponte, ma anche una risorsa sociale, significa restituirle la sua funzione più antica, quella di tenerci lontani dai pericoli, soprattutto quelli che si nascondono dietro un’apparenza rassicurante. Che, del resto, è quello che fanno i mostri. Da sempre.
(Oreste Patrone: 30 ottobre 2025)
CONSIGLI DI LETTURA
RUBRICHE: audiolibri | concorsi | ebook | editori | film | fumetti | libri | notizie | racconti | segnalibri | videogiochi
Dal 6 ottobre 2001 cultura horror a 360 gradi. I testi pubblicati in questo sito appartengono ai rispettivi proprietari. © 2026 Scheletri.com.
